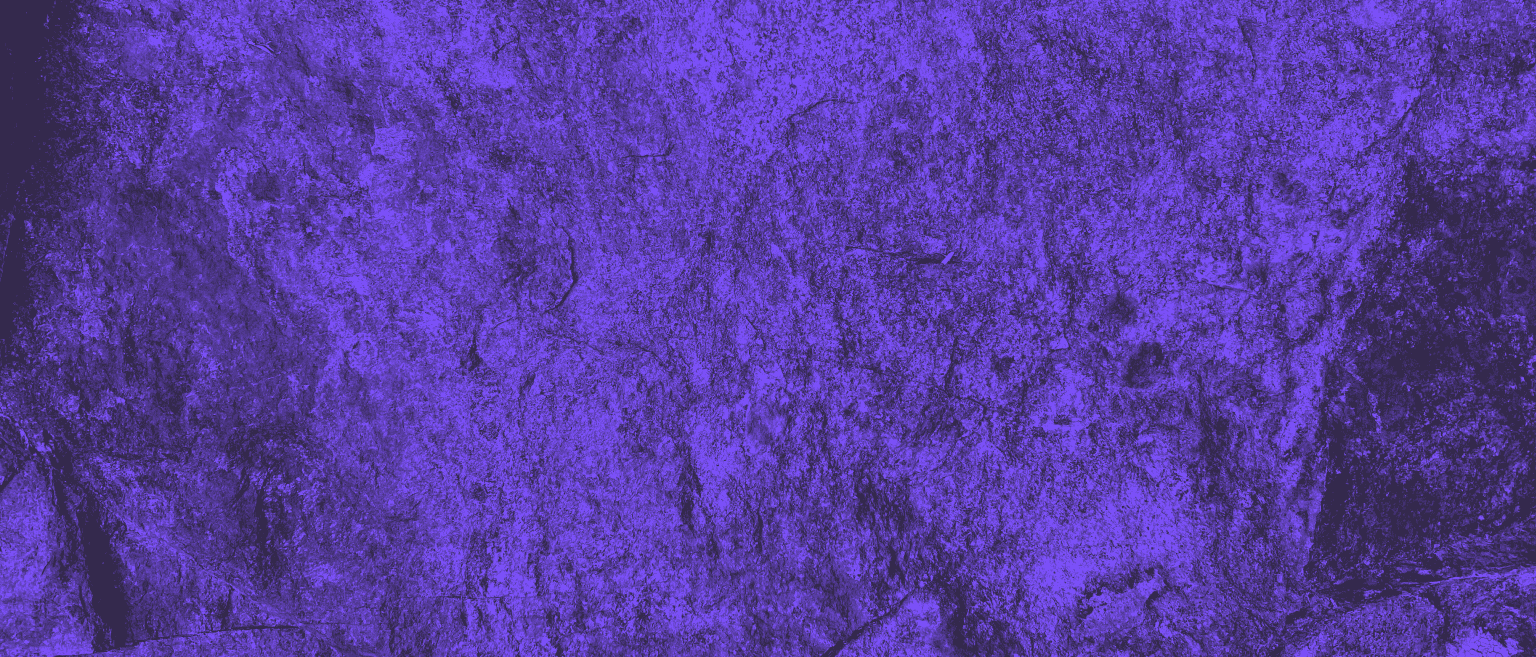Dopo avervi raccontato il caso della cooperativa Ippogrifo, tiriamo le fila su “chi è il community manager” e ci chiediamo che impatto stanno avendo queste figure chiave nel cambiamento organizzativo e nella costruzione di nuove forme di relazione.
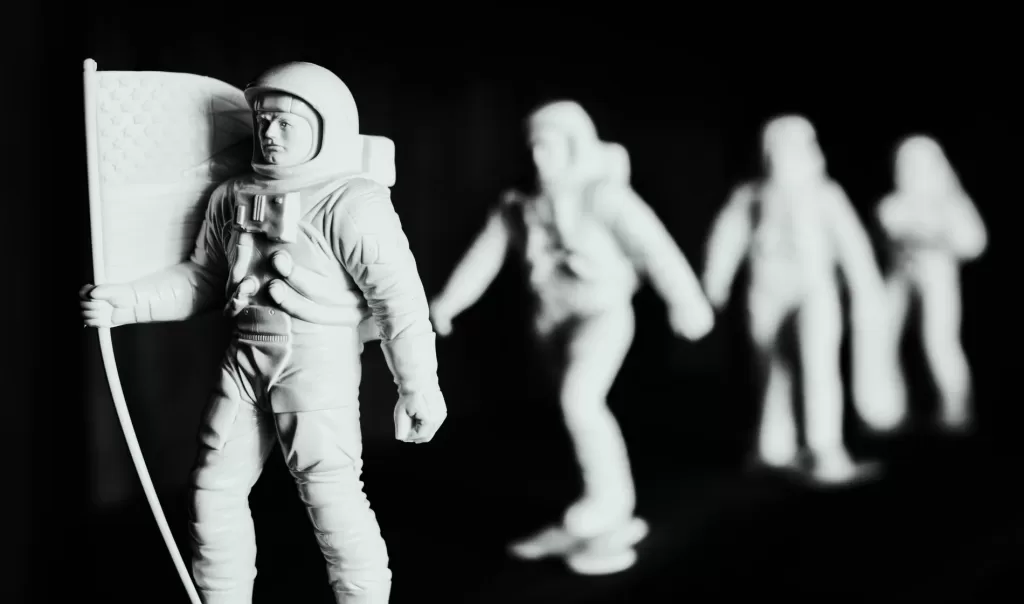
“I nostri dirigenti li abbiamo sempre scelti tra i responsabili di settore, i prossimi li sceglieremo tra i community manager”.
Uno slogan molto suggestivo, anche considerando da dove è scaturito: l’assemblea informale di un’importante impresa sociale milanese alle prese con il rinnovo del suo consiglio di amministrazione.
Detto questo, e perdonando la battuta fin troppo scontata, viene da chiedersi “che fare”? Come è possibile per un’organizzazione tradizionalmente infrastrutturata su filiere produttive contraddistinte invece da contenuti prestazionali e specialistici orientarsi verso funzioni e figure caratterizzate, nella vulgata ma non solo, da elementi di trasversalità e despecializzazione, più attente ai processi che ai prodotti? Per rispondere a questa domanda tutt’altro che teorica e molto orientata al change management occorre, in primo luogo, riannodare un legame non scontato tra “cooperazione” e “comunità” soprattutto se al centro si pongono obiettivi di cambiamento sociale, politico e organizzativo.
Partiamo dalla comunità come agente di cambiamento. Da cosa è caratterizzata nella fase attuale? Quali sono i suoi tratti evolutivi?
In sintesi, e riprendendo i contenuti di precedenti post pubblicati su questa testata, si potrebbero elencare alcune “capacitazioni” tipiche di un “approccio di pratiche” quali ridisegnare prodotti e servizi in chiave collaborativa; generare feedback d’impatto e non semplicemente di rendicontazione dell’esistente; influenzare la catena di produzione e la governance d’impresa in un’ottica di valore condiviso; agire sulla forma mentis individuale e soprattutto collettiva dando vita a nuove rappresentazioni sociali; alimentare la propria sostenibilità mobilitando un mix di risorse; operare in senso pragmatico senza “pagare dazio” a matrici politico culturali che agiscono ex ante.
E sulla cooperazione invece? Anche in questo caso si possono sintetizzare alcuni trend già evidenziati da ricercatori e practitioners: la massa critica in termini di numero e diffusione di imprese di questa specie (che gli scandali recenti, paradossalmente, contribuiscono a certificare); “l’esondazione” del meccanismo di cooperazione oltre la forma giuridica in senso stretto (pur con tutte le ambiguità legate a concetti ombrello come “sharing economy”); il fondamento antropologico e cognitivo del cooperare come tratto umano (indagato dalle neuroscienze fino all’antropologia culturale).
Facendo così convergere i termini della questione, e non semplicemente accostandoli, si possono osservare, e non da oggi, fenomeni di comunitarizzazione nel campo della trasformazione digitale, delle pratiche di gestione del lavoro e della produttività (le ormai vetuste “comunità di pratiche”), dei processi di intermediazione socioeconomica soprattutto su scala locale e, non per ultimo, delle tanto narrate, e forse sopravvalutate almeno in termini di output, “pratiche di resilienza” legate, ad esempio, al riuso di spazi e asset immobiliari. Allo stesso modo il cooperare ri-scopre la sua vocazione di impresa piattaforma più che matura nei contesti dove prevalgono produzioni distribuite e radicate (come in agricoltura) per tentare di mutualizzare il legame sociale nei contesti artificiali di un digitale sempre più pervasivo, piuttosto che per tenere in equilibrio il perseguimento di obiettivi di interesse generale che travalicano la compagine dei soci con l’esigenza di personalizzare e co-produrre i servizi.
Avvicinare cooperazione e comunità in senso organizzativo non è comunque facile. La strada è piena di ostacoli da rimuovere. Tra i principali si possono evidenziare: la tendenza a “sterilizzare” i processi produttivi rispetto ai contesti piuttosto che il loro irrigidimento attraverso l’utilizzo di procedure, cataloghi, sistemi di accreditamenti, certificazioni a cui si ispirano i sistemi di regolazione e i modelli di management dominanti; la segmentazione della domanda in base a profili di bisogno e financo antropologici e sociali ipersemplificati che contribuiscono a parcellizzare l’offerta al fine di indurre consumi prestazionali; la diffusione di sistemi di monitoraggio e controllo di gestione “output-oriented” che premiano competenze hard e organizzazioni verticali.
L’elenco potrebbe continuare ma la tendenza è chiara come anche le possibili soluzioni che consistono, come ricorda Benkler, nel ridisegnare organizzazioni non semplicemente come supporti ingegneristici e anodini ma come sense-maker, luoghi nei quali diversi stakeholder agiscono non solo sulla base di scambi contrattuali ma come produttori di significato per definire un’azione comune.
La strada del cambiamento organizzativo ispirata a questo principio lascia già intravedere soluzioni pratiche, alcune già in fase di avanzata implementazione ad esempio la produzione organizzata secondo criteri di distribuzione e di connettività (inter-settoriale e multi-locale); la ricerca e sviluppo come intelligenza collettiva orientata all’innovazione aperta e alla valorizzazione di competenze tacite; il design organizzativo che riconosce come nuclei base il team-working ispirato a modelli peer to peer e le reti che dilatano il classico approccio business to business; la governance improntata non su meccanismi decisionali iper codificati ma piuttosto, come ricorda Anna Grandori, su “regole costituzionali”; la valutazione che, citando Mario Calderini, sposta il focus su un cambiamento sociale intenzionalmente perseguito, assumendo in tal senso una connotazione “radicale”.
In sintesi i percorsi di change management di organizzazioni più cooperative in senso comunitario sono già cultura e prassi manageriale perché si diffondono pratiche di due diligence dei prodotti e servizi dove il processo produttivo viene ridisegnato in senso comunitario (co-produzione); i business plan sono basati non solo su core-business ma sulla cattura degli spillover (fare cose per far fare altro); la ricerca di marginalità deriva da economie coesive piuttosto che da prestazioni seriali estrattive (click economy); lo scouting e valorizzazione dei costruttori di comunità (non necessariamente all’interno dell’impresa) è pratica diffusa; la formazione è orientata non solo a trasmettere informazioni e competenze ma ad apprendere e replicare il social business adattandolo al contesto (scaling deep).
Tutti meccanismi che, nel loro insieme, chiamano in causa l’organizzazione come piattaforma in grado non tanto di presidiare ma di abilitare processi produttivi a partire da un riconoscimento chiaro dei propri asset patrimoniali accessibili per usi “comuni” che ne sappiano comunque incrementare (e non sfruttare) il valore. Tutto ciò richiede di maturare una meta competenza che corrisponde ad un mindset sistemico che sostituisca la razionalità mezzi-fini e che come tale non può solo essere “ formato” ma in un certo qual modo va “praticato”.Queste azioni infatti richiedono infatti di rielaborare una molteplicità di feedback, di riconoscere e valorizzare le esternalità, di far scalare l’innovazione emergente, di generare apprendimento condiviso, di promuovere l’educazione come fatto sociale, di promuovere politiche mission-oriented. Aspetti che inevitabilmente richiedono di acquisire una prospettiva di sviluppo integrale e “comprehensive”.
E in tutto questo il community manager che ruolo gioca?
Dall’osservazione di un’ampia e variegata casistica si rilevano almeno quattro macro funzioni:
- è una figura liminale, che sta a metà fra il dentro (l’organizzazione) e il fuori (comunità); guarda al contesto per innescare processi di ridefinizione organizzativa interna e ri-orientare l’agire;
- è un attivista che sa informare, promuovere, coalizzare per innescare processi di innovazione bottom-up;
- è un policy maker che accetta le regole del dialogo istituzionale stando ai “tavoli” che formulano politiche ed interventi “top down” connettendoli a dati di realtà;
- è un business angel che accompagna progettualità emergenti sostenendo con risorse diverse il carattere imprenditivo di comunità naturali e artificiali;
- è, paradossalmente, un product manager cioè veicolatore di prodotti e servizi dove la dimensione comunitaria è incorporata spesso sotto “mentite spoglie” (ad esempio dietro il bancone di un bar di quartiere o di una portineria).
Tutto questo operando in una posizione organizzativa sui generis che si potrebbe definire una “buffer zone” dove si intersecano diverse sfere organizzative, dove i processi rappresentano traiettorie che attraversano organizzazioni diverse, dove l’efficacia si misura sulla capacità di comporre coalizioni temporanee (leadership), dove si allentano le dinamiche formali della produzione e della governance, dove prevalgono: sperimentalismo, learning by doing, cross-fertilization. Elementi di trasformazione profonda che in effetti possono essere all’origine di una nuova generazione di imprenditori sociali.
Immagine di copertina: ph. Bruno Cervera da Unsplash
A cura di: Francesca Battistoni, Flaviano Zandonai
Pubblicato su: cheFare
Articoli correlati:
- Community management nei processi di innovazione aperta (1)
- Community management nei processi di innovazione aperta (2)